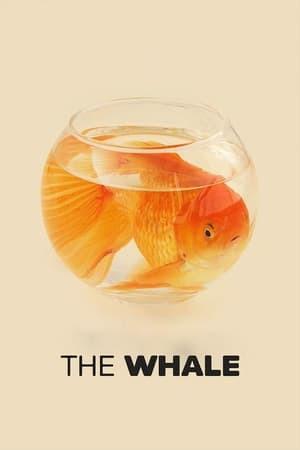Tentativo di balena
“Chiamatemi Ismaele”.
È tutto alla deriva.
Continenti, significati, relazioni.
Charlie si alza in piedi.
È sulle punte.
Un salto.
Un volo.
The Whale.
Di Aronofsky ho visto tutto. Per ragioni diverse, ho amato ognuno dei suoi film (solo Noah un gradino sotto tutti gli altri). Eppure è buffo, quando mi è capitato di fare, anche per gioco, una top ten di registi che più amo, lui non l’ho mai messo. La vita è strana. A ogni modo, mi sono avvicinato a The Whale con grande rispetto, e tanta voglia di vederlo. La visione è stata travolgente. L’ho sentito profondamente mio. Un’opera intima, potente, struggente. Ho pianto e ne sono contento.
I “salti” finali di Aronofsky sembrano essere un tratto ricorrente della sua poetica. Hanno molto in comune, da questo punto di vista, i personaggi di The Wrestler, Il Cigno Nero e The Whale: meglio morire di vita che vivere di morte. E allora si salta per raggiungere le stelle, toccarle anche solo per un attimo, prima di precipitare al suolo e frantumarsi. Perché è meglio morire da stella che vivere da buco nero.
L’obesità, mi pare evidente, è un elemento assolutamente marginale. Non è un film sull’obesità. Si tratta di una variabile che, appunto, avrebbe potuto essere qualunque altra cosa. L’alcolismo o il gioco d’azzardo, per esempio. Qualunque attività che possa fungere da punizione, da condanna, da reclusione, da espiazione. Avrebbe potuto essere anche la scrittura, o il cinema (vedi Just Don’t Think I’ll Scream), o la danza (Nina ne Il Cigno Nero), o lo sport (Randy the Ram in The Wrestler), o qualsiasi altro elemento: noi umani siamo bravi a creare prigioni con qualunque cosa.
Il parallelo con Cristo è sensato e opportuno. Del resto, Aronofsky utilizza spesso temi biblici, declinandoli in narrazioni che oscillano tra la metafora e la metonimia, tra l’inno e l’elegia, tra la celebrazione e la contestazione, tra l’universale e l’individuale. Charlie (insieme, per esempio, al John May di Still Life) è una meravigliosa rappresentazione di quel filosofo che duemila anni fa, sulle rive del Giordano, ha amato incondizionatamente ogni cosa, per il semplice fatto che esiste e che accade.
Charlie, appunto. Meraviglioso. Complesso. Terribilmente umano, eppure capace, alla fine, di alzarsi in volo. Come solo certi fiori, come solo certe balene.
Quel “mi dispiace”, ripetuto continuamente.
Un’ammissione di colpa. Una confessione. Una preghiera.
“Le persone sono meravigliose”.
“Le persone sono incapaci di non amare”.
In quel momento. Con quegli occhi. Con quella voce. Quando l’oceano è diventato pozzanghera e la balena sa di stare per morire.
Ellie. Bambina che si è dovuta dotare - troppo presto, troppo bruscamente - di difese contro l’assurdità della vita. Sola nella tempesta, come il più impreparato dei capitani Achab. Una bambina al timone di quella baleniera impazzita che è la propria vita senza padre, con una madre problematica, e tanto odio con cui innaffiare il mondo. E cerca disperatamente quella balena che gli ha mangiato il cuore. La troverà. Proverà a ucciderla. Ma si guardano negli occhi. Era inevitabile. Si riconoscono. “Tu sarai felice”. Luce bianca, bianchissima.
Liz. Un’anima buona che fa cose da umani. La solitudine e il dolore generano mostri che si mischiano con gli angeli che siamo (perché sì, le persone sono meravigliose, non lo capisco fino in fondo, ma io ti credo Charlie). Ho provato compassione per ciascuno di loro. Per ogni personaggio. Anche per il fattorino della pizza, che in quello sguardo sbalordito, disorientato, forse sgomento, racchiude lo stupore del mondo che è pozzanghera incapace di contenere i battiti del cuore di balena.
Perché poi, in fondo, la balena in questione è l’albatros di Baudelaire. Un’anima(le) che a terra è deriso, perché goffo, deforme, scoordinato: perché le sue ali di gigante gli impediscono di camminare.
E allora salta.
E allora vola.
E allora il mio tentativo di balena.